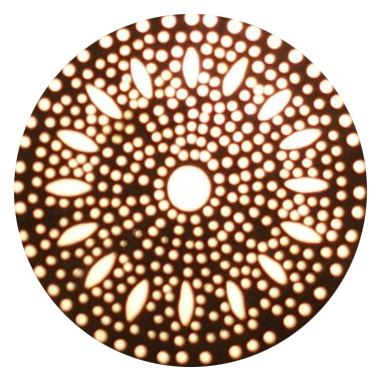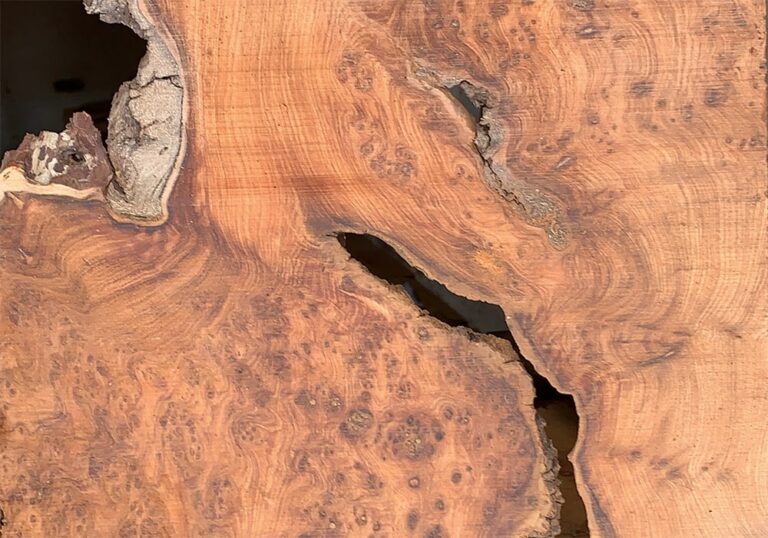Le voci di Marrakech, il viaggio di Elias Canetti
Il libro comincia subito, crudo, senza spiegazioni, con la descrizione di un cammello malato di rabbia e la fatica di chi lo governa. Non c’è introduzione romantica, ne’ ragionamenti sui motivi del viaggio, ma avventura, da subito, travaglio, passione. In Le voci Marrakech del 1964 Elias Canetti, Premio Nobel per la letteratura nel 1981, racconta un viaggio intrapreso negli anni Cinquanta per trovare una pausa durante la stesura del grande saggio che lo impegnò anni e lo avrebbe reso famoso in tutto il mondo: Massa e potere.
In questa sorta di diario di viaggio si avverte il senso di chi è portato via, lo straniamento di visitare un luogo, che allora, soprattutto in quegli anni, suonava come remoto. Nelle sue descrizioni magistrali e minuziosissime i cammelli, “tranquilli animali ricchi di curve”, hanno volti di vecchie signore. “Ricordavano quelle vecchie signore inglesi che prendono il te’ insieme con aria dignitosa e apparentemente annoiata” e gli uomini blu del deserto che vivono a Sud dell’Atlante acquistano la magia di esseri provenienti da un altro pianeta. “Il colore dei loro vestiti, ci avevano detto, si trasmette alla pelle, per questo sono tutti blu, uomini e donne, l’unica razza blu”.
E poi i souk, la descrizione dei mercati, che agli occhi del viaggiatore sembrano negozi di balocchiche inevitabilmente richiamano un modo ancestrale di stupire, che gioca su meccanismi di vendita quasi infantili. “Non ci stupiremmo se tutte le borse insieme cominciassero ad un tratto a muoversi ritmicamente, e ci rivelassero, in una pittoresca e orgiastica danza, la grande seduzione di cui sono capaci”. Le descrizioni sembrano incisioni fatte col bisturi per aprire il corpo oggetto di studio, in questo caso quel modo magico e misterioso di proporre la mercanzia, nel tentativo di svelare il meccanismo che sta dietro a quel sistema di vendita così lontano, come se ci fosse una pulsione bambinesca a rompere il giocattolo per scoprirne gli ingranaggi, nonostante stia proprio nel mistero e nell’impossibilità di svelarlo fino in fondo il segreto della sua magia. E questo Canetti lo sa bene. “Esiste un’intimità, che è seducente, tra il mercante e i suoi oggetti. Egli li custodisce e li tiene in ordine come se fossero la sua numerosissima famiglia. Non lo disturba e non lo angustia il fatto di conoscere con esattezza il loro valore. Perché egli lo tiene segreto e nessuno lo saprà mai. Questo conferisce alla contrattazione una nota appassionante e misteriosa. Solo lui può sapere quanto ci siamo avvicinati al suo segreto, ed è sempre all’erta, pronto a parare ogni colpo con destrezza, così che la distanza che protegge il valore non sia mai messa in pericolo ”.
Ne Le voci di Marrakech c’è un Marocco filtrato da occhi occidentali e raffinatissimi, raccontato da una penna quasi proustiana attenta a mescolare il fuori col dentro, ovvero il caleidoscopio di forme e rumori con le emozioni che queste suscitano, che è poi da sempre la grande potenzialità e il fascino della cultura marocchina, che a differenza dell’Africa più scura e lontana, si è lasciata sempre contaminare dall’Occidente. La letteratura ci racconta infatti, e non soltanto in Canetti, come in qualche modo il Marocco si sia sempre reso disposto a giocare col viaggiatore, provando a farsi capire, ma per poi ritrarsi all’ultimo, sempre tenendo il coltello dalla parte del manico. Perché in questo incontro di culture è sempre il Marocco a dirigere il gioco, a vincere, quasi nutrendosi dell’essenza di chi lo racconta. Quest’ultima sensazione infatti nel libro di Canetti emerge chiara: il Marocco come contaminazione infinita di cose che proprio nella sua complessità e multietnicità aperta agli stimoli trova la sua identità camaleontica, come una voragine che ingloba senza paura il viaggiatore, mangia, e non sempre sputa fuori, chi lo osserva. Si potrebbe dire che il Marocco in realtà si nutre di questi stessi sguardi. Non si lascia soltanto raccontare, ma in qualche modo è in grado di assorbire l’essenza di chi lo visita. Si pensi a Paul Bowles, a William Burroughs, a Jean Genet, “gente” che non è certo soltanto passata di lì, ma ne è rimasta felicemente, e volontariamente, intrappolata.